Bernardino d’Appennino
Un incontro-intervista del 2016 con frate Bernardino alla Romita di Cesi, sul senso dello stare in montagna, sulla filosofia dei boschi, sui sentieri e sui conventi francescani…
Il nostro ospite c’aspetta in alto. Anzi, lassù lui ci vive e per arrivarci occorre camminare su un sentiero già percorso da secoli, come in una interminabile processione tra gli alberi.
Nello zaino mettiamo qualche dolce natalizio, perché l’ospitalità, da queste parti, va sempre ricambiata.
Ci siamo allontanati di qualche chilometro dalla catena principale dell’Appennino. Siamo sulle pendici di un piccolo Appennino, una sua propaggine. O meglio, un Appennino in disparte. Sono i monti Martani, un massiccio che si allunga per circa 60 chilometri, in direzione Sud-Nord, parallelo alla Valnerina e dunque all’Appennino Umbro-Marchigiano, ma – tanto per farsi notare – se ne distacca, proprio al centro dell’Umbria, tra la Valle Umbra e la Val Tiberina.
 Per essere meno maligni sulla vanità dei monti Martani, potremmo invece dire che il loro isolarsi, in fondo, è solo un gesto gentile nei confronti dei camminatori che intendano ammirare dall’alto una delle regioni più belle d’Italia.
Per essere meno maligni sulla vanità dei monti Martani, potremmo invece dire che il loro isolarsi, in fondo, è solo un gesto gentile nei confronti dei camminatori che intendano ammirare dall’alto una delle regioni più belle d’Italia.
Questi piccoli monti di mezzo (raramente le loro cime erbose e arrotondate superano i mille metri d’altitudine), sono infatti un balcone naturale, luogo ideale per guardarsi intorno, per spaziare sulla verde valle Umbra e oltre: dal Subasio al Terminillo, dai Sibillini al Gran Sasso, da Assisi a Montefalco, fino a Trevi e Spoleto. Se poi ci si sposta appena un po’ dall’altra parte del crinale, ecco lo spettacolo di Todi tra le nebbie della val Tiberina, della più bella campagna umbra, dei colli di Perugia e della conca ternana.
Tutto a volo d’uccello, come piaceva tanto ai futuristi umbri e al perugino Gerardo Dottori, aeropittore innamorato della sua terra, che amava dipingere dall’alto.
I Martani, insomma, sono un gran belvedere, pieno di storia e di sorprese. Furono il luogo privilegiato dove gli antichi Umbri edificarono i loro osservatori augurali e i templi celesti, prima ancora che i Romani arrivassero anche qui da conquistatori. Furono un feudo longobardo, le Terre Arnolfe, con la Contea del Monte, la Contea del Piano e la Normannia. Furono le terre montane contese tra i bellicosi Comuni umbri, tra guelfi e ghibellini. E infine furono i monti mistici, percorsi da monaci e santi.
E così, la prima riflessione che ti viene in mente quando ti lasci alle spalle gli uliveti, t’infili nel bosco e ti avvii sulle prime giravolte del sentiero, è che camminare in questa parte dell’Appennino (o del sub-appennino) umbro senza incrociare un sentiero dove passò Francesco, è quasi impossibile. Francesco d’Assisi camminava proprio qui: saliva montagne, attraversava boschi, si beava del creato, cantava con gli uccelli e ululava coi lupi. S’immergeva, letteralmente, nella natura.
E dove, meglio che sui monti dell’Umbria e della Sabina? O nelle foreste del casentino e della Verna: dolcezza e selvaticità, asprezza e armonia. Boschi che a vederli da lontano li vorresti carezzare, ma che sono talmente fitti da farti perdere la strada. Se ami il mondo devi apprezzarne le contraddizioni, anche quelle all’apparenza più piccole. E l’Appennino te ne offre sempre uno specchio.
Francesco l’ha preso in mano questo specchio e c’ha guardato dentro. Ma non c’ha visto solo il suo volto. C’era un riflesso della natura e di lui, piccolo uomo, nelle sue braccia. Che poi erano i rami degli alberi. Dei lecci, scuri e tenebrosi che sotto i mille metri d’altitudine popolano la macchia umbra.

Proprio quei lecci, narra la leggenda, s’inchinarono in una fredda mattina del 1213, quando Francesco percorse questo sentiero che sale da un diverticolo dell’antica via Flaminia sulla montagna di Cesi, sopra le rovine di Carsulae, municipio romano tra Terni e Acquasparta.
In una verde radura, a 800 metri d’altezza, appena sopra il corso di un fosso e sotto la cima del monte Torre Maggiore dove venne innalzato un tempio italico ben prima di Roma, Francesco trovò – così come gli avevano indicato – una piccola cappella benedettina. Vi restò più di un mese, componendovi l’Exhortatio ad laudem dei, antefatto del Cantico delle Creature. Tornò più volte in questo luogo sperduto e al centro della natura.
Pian piano la cappellina diventò una chiesa e le capanne un convento francescano dell’Ordine dei Minori. In questo deserto montano, come lo chiamavano i cronisti del Seicento, transitavano i pellegrini verso il Perdono di Assisi, i fratres di Francesco, e poi san Bernardino che predicava contro l’usura e lasciava come segno luminoso del suo passaggio il sole dell’orifiamma.
 E siccome il sentiero era tracciato, tanto tempo dopo, nel 1991, in quest’angolo di Appennino in disparte, è arrivato un altro Bernardino. Anche lui destinato a riportare un po’ di luce al posto dell’oscurità.
E siccome il sentiero era tracciato, tanto tempo dopo, nel 1991, in quest’angolo di Appennino in disparte, è arrivato un altro Bernardino. Anche lui destinato a riportare un po’ di luce al posto dell’oscurità.
Oscure erano divenute le celle dei frati, la grande sala del noviziato era ricoperta d’edera. Luce entrava ancora nella chiesa, ma solo perché il tetto era caduto giù, i coppi antichi rubati su commissione per costruirci una bella villa in stile nella campagna umbra.
Il convento, d’altra parte, era già stato profanato nel 1867 dai bersaglieri del Regno d’Italia nella furia anticlericale che non faceva distinzione tra gli sprechi dei patrimoni cardinalizi e gli spechi francescani.
Cacciati i fraticelli, spinti via dal desco mattutino con le baionette, La Romita (questo il nome del convento montano) venne venduta dal nuovo Stato italiano, come tanti altri beni requisiti alla Chiesa. Divenne casa di contadini e carbonai, poi stalla, infine rudere, seguendo in questo percorso apparentemente senza ritorno, il destino della montagna in via di spopolamento.
Ma Francesco d’Assisi aveva ben seminato. E una buona semina dà frutti duraturi, anche se occorre aspettare la stagione propizia.
Bernardino è l’ospite che ci attende. Sotto l’enorme cedro del Libano che sembra proteggere il convento dell’Eremita. Fu la prima cosa che attrasse la sua attenzione quando arrivò qui. Ed è la prima cosa che attrae anche noi, visitatori di oggi.
Bernardino trovò il convento in abbandono sotto al cedro, quasi sommerso dai rovi e dai rampicanti, che però hanno naturalmente sostenuto le pietre francescane, quasi abbracciandole. Lo guardò, carezzò le pietre, e sentì la loro voce. Da quel giorno del ’91, Bernardino non ha più lasciato sole quelle pietre.
Ha progettato, ha parlato, ha convinto, ha entusiasmato, ha sudato e preso freddo. Ha riscaldato tanti cuori. Ha fatto lavorare tante persone, ricambiandole con un sorriso e con il dono di una visione, o meglio di un sogno da coltivare, oltre che di un pasto da consumare insieme sul prato o davanti al focolare del convento.
Il risultato è lì, al termine del sentiero, subito dopo un suggestivo passaggio tra le rocce e un interminabile muro a secco costruito dai frati con pietre enormi rotolate giù dal bosco, oggi ammantate di muschio.

Il convento dell’Eremita è tornato ad essere un luogo accogliente. Restaurato senza grandi progetti architettonici, ma con la semplicità francescana, sulla quale non ha avuto niente da ridire neanche la Sovrintendenza. Sulla radura verdissima che esalta il candore delle pietre calcaree con le quali è solidamente costruita la piccola cittadella del convento, Bernardino ha ricavato il suo orto. Appena più in là c’è il recinto delle capre. Al centro del prato un antico colonnato sostiene un tetto sotto il quale c’è il pozzo della cisterna che dà acqua al convento. Di fronte, un semplice altare ricavato dal tronco di una quercia e, davanti, tante assi ordinate e sostenute da pietre. Servono come sedili per le celebrazioni all’aperto, come quella del 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, che richiama qui centinaia di pellegrini, la maggior parte dei quali ha fatto parte dell’esercito dei volontari che ha contribuito a ricostruire il convento pietra su pietra. Su quel rustico altare Bernardino, invece dell’ostensorio e dei calici dorati, è solito collocare i frutti della terra e dell’orto. Una grande zucca, i grappoli d’uva, i fiori.
Bernardino è qui, nel suo posto, nella sua esistenza. E’ un frate francescano, o non lo è più, oppure lo è stato per tutta la sua vita e lo è ancora, più degli altri, più di ogni altro. Non importa. Bernardino è qui. Custode di questo luogo montano, padrone di nulla.
A volte più che come custode, piace immaginarlo come il signore del luogo. Signore nel senso etimologico, di senior, anziano, conoscitore del luogo, riferimento di quel luogo. Del quale non è proprietario, quanto piuttosto artefice, o meglio ri-costruttore. Un suo confratello, un frate argentino che si chiama Guglielmo Spirito, ha scritto uno straordinario saggio in cui parla di San Francesco e di Tolkien, tracciando inconsueti e interessanti paralleli tra il mondo fantastico creato dal professore di Oxford e la vita reale del santo di Assisi.
Il paragone più ardito e suggestivo quello tra Francesco e Tom Bombadil, il curioso personaggio de “Il signore degli anelli” che vive nei boschi, in armonia con il Creato. Dei boschi Tom Bombadil è signore, mai padrone. E su di lui l’anello del potere non ha alcun effetto. Se glielo si affidasse, se lo dimenticherebbe da qualche parte. E così Tom Bombadil canta nella natura, cerca armonia, non diversamente da un poeta come Velimir Chlebnikov (Per me è molto più piacevole ascoltare la voce dei fiori/ che sussurrano «È lui» chinando la testolina quando attraverso il giardino/ che vedere gli scuri fucili della guardia uccidere quelli che vogliono uccidere me./ Ecco perché io non sarò mai, e poi mai, un Governante) o di uno scrittore come David Thoreau che cercava nella natura il rifugio “dalla quieta disperazione della vita cittadina”.
– Mettiamoci di fuori!
C’è ancora un bel sole. L’aria è pulita come nei rifugi alpini. La neve non è arrivata ed il bosco di fronte alla terrazza del convento è magnifico e brillante nel caleidoscopio dei suoi colori di fine autunno.
– Che ne dici? Non è meglio della televisione? Bernardino è pugliese. Di cognom e fa Greco. Ha i capelli bianchi, ora. Ma restano i ricci, una corona di ricci, le mani ruvide di uno che ha lavorato tanto e la parola mite e mai inutile di uno che ha studiato due volte, nei libri e nella natura. E gli occhi vivaci, accesi, come il fuoco alimentato nel grande camino del convento. Fratello foco. Il primo compagno di Bernardino, quando nel 1992 decise di ri-abitare questo luogo abbandonato e sottoposto ad uno scempio angoscioso, è stato proprio il fuoco. E i monti. Anche se Bernardino montano non è. Almeno d’origine. Ma i monti erano nel suo destino fin da ragazzo.
e fa Greco. Ha i capelli bianchi, ora. Ma restano i ricci, una corona di ricci, le mani ruvide di uno che ha lavorato tanto e la parola mite e mai inutile di uno che ha studiato due volte, nei libri e nella natura. E gli occhi vivaci, accesi, come il fuoco alimentato nel grande camino del convento. Fratello foco. Il primo compagno di Bernardino, quando nel 1992 decise di ri-abitare questo luogo abbandonato e sottoposto ad uno scempio angoscioso, è stato proprio il fuoco. E i monti. Anche se Bernardino montano non è. Almeno d’origine. Ma i monti erano nel suo destino fin da ragazzo.
– Sono nato in Puglia, a nord di Taranto. Lì abbiamo solo qualche collina, che chiamiamo monte. Ma i monti veri li ho iniziati ad incontrare in Umbria, a Gubbio, dove ho fatto il collegio a dieci anni. Ero nel convento di San Girolamo, sul monte Ingino, negli anni ’50. – Lì ho scoperto i boschi, il silenzio, il panorama dall’alto, la bellezza del paesaggio, il senso del distacco dal rumore e dalla confusione. Gli anni successivi mi hanno portato in altri conventi, tutti in località con il nome di un monte: Montesanto a Todi, Monteripido a Perugia.
La via dei monti d’Appennino, dunque, era già imboccata. Però mancavano ancora dei buoni compagni.
– Vero. Ma proprio allora ho iniziato ad incontrare San Francesco, a camminare sui suoi passi, a far mio il suo senso del selvatico, il fascino della natura incontaminata, l’amore per il bello.
Bernardino non ne parla in questa occasione. Ma la sua formazione religiosa, in gioventù, lo portò ben più lontano dei conventi umbri. Fu studente alla facoltà di Teologia cattolica dell’Università di Tubinga, in Germania. E lì ascoltò le lezioni di Joseph Ratzinger e di Hans Küng. Alla fine, per la sua tesi, scelse Küng. Di quell’esperienza restano tanti contatti e tante amicizie che ancora portano molti tedeschi sui sentieri della Romita, ospiti e collaboratori di Bernardino.
San Francesco e l’università di Tubinga: tanta fatica e tanto studio, per cercare di capire, per allargare il proprio orizzonte, la propria visione. Come quando si sale su una montagna…
– La montagna è il luogo dell’incontro dell’uomo con Dio. Oltre la vetta c’è solo il cielo, un accesso diretto con il cielo.
E di montagne qui intorno ce ne sono tante. Basta prendere il sentiero di fronte al cancello del convento, che sale nella lecceta, tra pietre muschiose, e poi s’inerpica nella faggeta tra i grandi tronchi-colonna bianchi come la pietra di una cattedrale romanica, fino ai prati sommitali.
– Di qui, in un’ora, si va sulla cima di Torre Maggiore, la montagna che amo di più: per gli antichi era un osservatorio celeste. Se ci sali ti rendi subito conto del perché: è un luogo con un orizzonte molto vasto, a 360 gradi. Dalla vetta si vedono cinque regioni e tutti i principali massicci dell’Appennino centrale.
Ma non è solo una visione da geografo, quella di Bernardino, dall’alto della sua montagna appenninica. Sorride se glielo dici. Ha già pronta la sua risposta.

– Mi chiedi a cosa serve la montagna? A che serve guardare il panorama? Ti dico l’effetto che fa a me: serve a vedere le cose nella loro giusta dimensione. Da qui tutto quello che a valle ci sembra gigantesco, appare invece piccolo. La montagna c’insegna i nostri limiti, c’insegna a relativizzare.
Salire e ridiscendere. Vedere dall’alto e poi riportare giù questa visione, come diceva René Daumal ne Il Monte Analogo. Ma questo stesso concetto, prima di lui, qualcun altro era stato capace non solo d’intuirlo, ma di renderlo concreto.
– Francesco d’Assisi saliva spesso sulle montagne – su queste montagne – camminava e vi si ritirava. Poi però riscendeva a valle a predicare. Saliva, vedeva e si ricaricava, per poi riportare tutto giù, in pianura, e condividerlo con gli altri.
C’è un senso del sacro che è connaturato all’uomo. O almeno lo è nell’uomo naturale, nell’uomo che vive nella natura e ne ha consapevolezza. Il sacro non è razionale, non sta dentro lo sguardo della mente, come il panorama che si apre dalla vetta di una montagna, verso l’alto e verso il basso, verso dovunque. Davvero, lo avvertiamo, lì, che non basta certo la nostra testa per contenerlo. E lo avvertiva, probabilmente anche Francesco. Senza la necessità di essere un alpinista.
– Francesco – dice Bernardino, svelando l’essenza del santo d’Assisi – era un uomo universale, un uomo cosmico: nel Cantico parla anche dell’uomo, ma non lo pone al centro: l’uomo non è l’unica realtà. L’uomo è nella natura. È nel cosmo.
In questo senso, quel gran camminatore di Francesco seguiva le orme dei Padri. Certo, lui conosceva la Bibbia, “ne aveva assorbito l’essenza”. Ma avesse incontrato uno sciamano, un indiano d’America, o forse più semplicemente un augure dell’antico popolo degli Umbri che passava di qua duemilacinquecento anni fa, non lo avrebbe sentito distante.
Di questa sua attenzione al sacro, tutta naturale, da anteporre alle forme, ne è testimone la sua posizione sull’Islam.
– Mentre si offrivano indulgenze a chi andava a fare le Crociate, mentre l’islam prometteva il paradiso a chi moriva in battaglia, Francesco diceva che le indulgenze si potevano ottenere anche girando per i nostri monti per la Porziuncola, per Greccio, dove inventò il presepe, per La Verna dove ricevette le stimmate.
Molti luoghi francescani appenninici portano l’appellativo di speco. Perché sono vicini ad una grotta, ad una caverna, una spelonca, dove Francesco amava ritirarsi, come a La Verna, come a Narni o a Cesi. Ma speco, secondo un’etimologia, vuol dire anche foro attraverso il quale si guarda. Ed è assonante a speculum, allo specchio, ovvero all’oggetto che, specie nel Medio Evo, stava a simboleggiare un modo di guardare la realtà.
Guardare le cose nell o specchio, o nella sua versione attuale, nello schermo, quello dei nostri tablet, degli smartphone… Oppure guardarle direttamente, sentirle con i tutti i sensi. Carezzare le pietre, ponderarne il peso, sentire il profumo del muschio e la puzza delle deiezioni caprine, la brezza che porta l’annuncio della neve, il calore del sole di marzo dopo un inverno trascorso a proteggersi dal freddo.
o specchio, o nella sua versione attuale, nello schermo, quello dei nostri tablet, degli smartphone… Oppure guardarle direttamente, sentirle con i tutti i sensi. Carezzare le pietre, ponderarne il peso, sentire il profumo del muschio e la puzza delle deiezioni caprine, la brezza che porta l’annuncio della neve, il calore del sole di marzo dopo un inverno trascorso a proteggersi dal freddo.
Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem, diceva San Paolo. Qui, da Bernardino, in montagna, nello speco francescano, l’enigma dello specchio si svela nel faccia a faccia.
– La Romita – dice Bernardino – mi ha consentito un’esperienza diretta, tante esperienze dirette. Innanzitutto la ricostruzione, quella fisica delle pietre che mi hanno chiamato qui e quella interiore. Infine la ricostruzione della comunità. Un’esperienza di contatto diretto, prolungato, fisico e visivo. Il lavoro con le pietre, il lavoro sulla terra, il lavoro con gli animali. Con gli elementi primordiali: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco: l’esperienza del cantico.
Un benedettino, il priore di Norcia, padre Cassian, in una omelia ha messo in guardia i suoi monaci. Ricordando la Regola ha detto che un buon monaco ha a cuore i libri e lo studio, ma prima ancora deve avere a cuore le pecore e sapere come governarle, perché è con la pelle della pecora che si fanno le pergamene per i libri.
La via benedettina e quella francescana. Talvolta s’incrociano. Anche in montagna.
– Negli altri conventi, anche in quelli francescani – dice ancora Bernardino – ci sono ormai i termosifoni, le caldaie. E allora non puoi più vedere i salti del fuoco, i suoi movimenti, la sua luce, le scintille che salgono su per la canna fumaria.
– Qui alla Romita non c’è acqua corrente e non c’è riscaldamento, bisogna saper coltivare l’orto, allevare le capre e per arrivarci bisogna sudare un po’. Tutto va guadagnato, anche la bellezza di fare la cose insieme…
La montagna è stata per tanti secoli sinonimo di solitudine, ma anche di comunità forti. C’è un’apparente contraddizione tra questi due concetti: solitudine e comunità. Ma è davvero così?
– Solitudine e comunità, sono come il silenzio e l’accoglienza: stanno insieme naturalmente. Vivere sulla montagna non vuol dire stare da soli. Così come faceva Francesco, occorre condividere ciò che si guadagna qui, specie in termini spirituali. Il tesoro che hai scoperto non lo puoi tenere per te, lo devi trasmettere agli altri.
Bernardino guarda il bosco che è qui davanti e riempie gli occhi. Un monumento verde? No, un quadro di vita!
– Bisogna essere come un albero del bosco, dice. In che senso? – Vivere da soli e insieme. Ogni albero ha un’identità, ma gli altri alberi lo proteggono dal vento. Gli alberi si difendono insieme e si concimano uno con l’altro. Il bosco è vita di comunità. – Il bosco, la natura e la comunità soffrono se non c’è empatia, quando se ne turba l’armonia. Come quando vengono con le motociclette qua in mezzo, aggiunge sorridendo e indicando con la mano il sentiero violato dalle moto da trial. – Allora il bosco soffre. Perché il bosco non è qualcosa; è qualcuno. – Troverai più nei boschi che nei libri, conclude ridendo ancora e citando Bernardo da Chiaravalle.
 Rientriamo nella sala del noviziato. C’è pietra alle pareti, legno in terra, tavoli massicci, piccole finestre di luce che filtrano colori azzurri e verdi, ritagliando le immagini della natura meglio di quanto possa fare la miglior riproduzione artistica. Veniamo avvolti da una sensazione di tranquillità e sicurezza. L’interno del convento montano è un luogo accogliente.
Rientriamo nella sala del noviziato. C’è pietra alle pareti, legno in terra, tavoli massicci, piccole finestre di luce che filtrano colori azzurri e verdi, ritagliando le immagini della natura meglio di quanto possa fare la miglior riproduzione artistica. Veniamo avvolti da una sensazione di tranquillità e sicurezza. L’interno del convento montano è un luogo accogliente.
– Dobbiamo creare, ricreare e conservare posti accoglienti e in armonia, per favorire e incrementare l’uscita delle persone dalle città; per questo occorre prendersi cura della montagna.
La montagna. C’è qualcuno, dunque, che le affida un ruolo. Può ancora servire a qualcosa?
– Sì certo, la montagna ci aiuta a metterci in discussione. A farci capire che l’uomo non è il padrone della natura, è natura. Per questo, come insegnava San Francesco, occorre benevolenza, empatia verso la natura, anche quando questa appare cattiva come il lupo. Ma l’aggettivo cattivo non appare mai nel cantico.
– La montagna oggi è disabitata, ma una volta la gente viveva qui. Non c’erano solo i frati. C’erano tante famiglie. I carbonai, gli allevatori. La terra, anche qui davanti al convento si poteva coltivare.
E oggi? Oggi, come dice Giovanni Lindo Ferretti, la montagna è al massimo un’amante da frequentare nel fine settimana…
– No – replica Bernardino – si potrebbe ancora vivere qui. Ma non è necessario tornare al passato. Occorre fare tesoro del presente e degli strumenti che il presente ci offre. La montagna ci aiuta a non farne degli idoli, anche in questo caso li relativizza. E così anche qui abbiamo i pannelli solari, le pompe meccaniche e Internet, ma cerchiamo di usarli in armonia con la nostra vita reale, quella che conduciamo ogni giorno qui.
– La montagna è rinuncia a tante cose che facilmente si trovano a valle, ma è anche l’occasione d i guadagnarne tante altre che giù non riusciamo neanche a vedere. La montagna ci aiuta a ritrovare un equilibrio naturale e spirituale, perché il progresso e la crescita non sono infiniti. Le risorse non sono infinite. La montagna c’insegna la fatica che occorre per procurarsi i frutti. Ci ricorda i ritmi della natura, l’importanza dell’alternarsi delle stagioni.
i guadagnarne tante altre che giù non riusciamo neanche a vedere. La montagna ci aiuta a ritrovare un equilibrio naturale e spirituale, perché il progresso e la crescita non sono infiniti. Le risorse non sono infinite. La montagna c’insegna la fatica che occorre per procurarsi i frutti. Ci ricorda i ritmi della natura, l’importanza dell’alternarsi delle stagioni.
– Certo, è vero. Adesso in montagna non ci abita più nessuno, solo idealisti come noi. Ma in montagna è possibile vivere, lo ripeto ancora. Anzi, forse tra un po’ sarà necessario. E allora – sorride Bernardino – chi ha manualità, chi conosce gli alberi, il legno e la pietra sarà favorito: conoscere la natura è sempre stato un elemento in più per garantire la sopravvivenza.
Ma non è solo un problema di adattamento alle difficoltà e di conoscenza pratica. Per vivere in montagna, per voler vivere in montagna, forse serve qualche altra cosa…
– Sì, dice Bernardino. Serve la capacità di stupirsi. Di conservare lo stupore, di fronte a un albero, a una foglia, a una nuvola. Lo stupore è l’inizio della gioia. Se non si ha la gioia che si vive a fare? A che servono i soldi e la macchina nuova?
Bellezza, senso del sacro, natura: la Romita parla al viandante, e Bernardino è solo il suo interprete. Con la sua montagna è un tesoro nascosto, eppure così vicino. Basta un piccolo sforzo per arrivarci.
Il fuoco ormai è acceso e una tisana ha rilassato i muscoli. Ma è sera e occorre riprendere il sentiero verso la valle. Si riscende. Bernardino resta a custodire la Romita. Che non è costruita solo di pietra.
Un’ultima domanda: ma perché San Francesco camminava così tanto?
– L’uomo non è stabile, l’uomo è in cammino, la sua vita è un transito. L’uomo è un uccello migratore. Il camminare t’impedisce di fissarti su un pensiero. La fissazione a volte può distruggere la mente. Spostarsi, camminare, specialmente in montagna, apre nuovi orizzonti.
Come lungo i sentieri d’Appennino. Specie lungo quelli più in disparte.


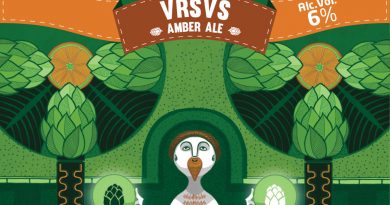


Pingback: Appennini, un sentiero lungo un anno – APPENNINI
Pingback: Curarsi con le pietre, i santuari terapeutici in Appennino - AppenniniWeb
je visite l’ensemble des articles du website c’est toujours super fait ne changez rien
Pingback: Angeli e dèmoni in Valserra, i segreti del Rivosecco - AppenniniWeb
Pingback: Sintesi d'Appennino, perché Cesi ha vinto la lotteria del PNRR - AppenniniWeb